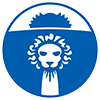10/09/2009
Daniel Mendelsohn con Gad Lerner
2009_09_10_023
«Non sono tra coloro che pensano che la poesia sia finita dopo Auschwitz, credo semmai che l'arte sia il modo più discreto e incisivo per esplorare l'inesplorabile». Ebreo americano, critico letterario ed esperto di teatro classico, Daniel Mendelsohn ha scelto con "Gli scomparsi" una nuova strada per entrare in rapporto con il passato della propria famiglia e dell'olocausto. Tra racconto autobiografico, indagine poliziesca e dialogo con i testi della tradizione ebraica, la scrittura di Mendelsohn punta a recuperare la voce e la vita delle persone perdute per fare in modo che non vadano disperse nel massacro gigantesco e senza volti. Lo incontra il giornalista Gad Lerner.
English version not available
Italiano
Inglese
Inglese
Inutile voler negare che la stragrande maggioranza dei presenti nel Cortile della Cavallerizza voglia vedere e ascoltare lui: Gad Lerner. Il giornalista italiano nato a Beirut nel 1945, viene accolto da un applauso degno di una vera star. È qui per colloquiare con Daniel Mendelsohn, scrittore e critico letterario dagli occhi di un blu intenso e profondo, come profonde sono le radici ebraiche che uniscono i due intellettuali. L'intero incontro è incentrato sul concetto di «ricognizione ed elaborazione» della sofferenza del loro popolo e del bisogno di investigare il passato, ripercorrendone i luoghi alla ricerca della propria identità. L'americano, con il suo romanzo autobiografico "Gli scomparsi", vuole forzare il lettore a capire la necessità del dolore, ad accettarlo come elemento fondamentale di un'esistenza ricca di significato, poiché nella vita a volte ci sono ferite troppo profonde per poter essere sanate. Prende poi le distanze dal 'turismo dell'olocausto', di chi cioè si vuole comodamente appropriare delle esperienze altrui, dello statuto di vittima, crogiolandosi nel sentimentalismo. Malgrado la tematica sia impegnativa l'incontro riesce a scorrere lieve, anche grazie alle domande cadenzate dell'esperto Lerner, che conclude domandando al collega quale sia il rapporto che lega le sue due professioni, al che il giovane risponde scherzando: «non c'è dubbio... come scrittore studio la sofferenza, mentre come critico la infliggo!». Gad Lerner presenta Daniel Mendelsohn come uno scrittore insolito: un intellettuale ebreo di formazione classica che per cinque anni ha cercato di trovare una risposta alla domanda che lo assillava fin da bambino: che fine fece suo nonno Shmiel in Polonia, durante l'Olocausto? Questo interrogativo è culminato nel capolavoro "Gli scomparsi" uscito lo scorso anno per Neri Pozza e seguito, in questi mesi per lo stesso editore, da "Bellezza e fragilità". Il giornalista italiano si sente naturalmente concittadino dell'autore statunitense, in ossequio a quella regola per cui tutti gli ebrei del mondo hanno lo stessa origine comune: in questo caso, anche geograficamente il paese natale di Lerner è molto vicino alla Bolechow descritta ne "Gli scomparsi". Dapprima in un ottimo italiano, poi sconfinando nell'accento nasale tipico della costa newyorkese, Mendelsohn risponde con tono pacato e cordiale alle domande di Lerner. La prima domanda riguarda da vicino la formazione dello scrittore statunitense: quanto aiuta, al giorno d'oggi, riprendere il filo della tragedia classica per superare gli ostacoli quotidiani? È un riferimento non troppo velato al recente saggio breve di Mendelsohn (pubblicato sulla "New York Review of Books") come recensione di uno dei maggiori casi letterari degli ultimi anni, "Amabili resti" di Alice Sebold. Il libro in questione, uscito per coincidenza un anno dopo l'11 settembre, catturò il sentimento nazionale di un popolo di fronte alla morte di tanti innocenti; aiutò, quindi, a 'sopportare' meglio un male vissuto in diretta, restando vicini ai propri morti e trovando così una consolazione, seppur piccola. La stessa famiglia di Mendelsohn fu sconvolta da qualcosa che non si poteva raccontare: lo scrittore riconosce che, visto il periodo storico in cui viviamo, sarebbe facile cadere nel sentimentalismo fine a se stesso, fingendo di affrontare il dolore per poi illudersi di sconfiggerlo. «Ma - provoca Mendelsohn - chi ha detto che la guarigione sia l'unica cosa che conta?». Lerner chiede se non possa essere una nevrosi, per un bambino dodicenne, interrogarsi sui pochi tasselli rimasti della storia dei propri nonni. Premettendo che, in verità, «nessun ebreo avrebbe qualcosa da obiettare se gli dicessero che è nevrotico», lo scrittore spiega che lui è stato l'unico, di cinque fratelli, ad avere sentito il bisogno di ritornare al proprio luogo natio; anche se, in fondo, sia Lerner che Mendelsohn videro il paese d'origine della loro famiglia pochissimi anni fa e, dunque fu una 'prima volta' a tutti gli effetti, in sospensione fra passato, presente e futuro. A questo proposito il giornalista italiano apre una parentesi tornando idealmente all'incontro che lui stesso tenne insieme a Jonathan Safran Foer a Festivaletteratura, esattamente un anno fa nel medesimo luogo. Fu l'autore di "Ogni cosa è illuminata" a confessare di «voler vedere il luogo in cui sarei dovuto nascere». Entrambi gli ospiti convengono che, in effetti, un'affermazione del genere rischia di essere facile preda del sentimentalismo di cui sopra, portando all'esasperazione il vittimismo e arrivando addirittura a creare falsi ricordi dell'Olocausto: «Il 'turismo del passato' non deve diventare una sorta di Disneyland», ammonisce Mendelsohn, citando come esempio il Museo dell'Olocausto di Washington, in cui i visitatori sono invitati a 'salire' sui vagoni bestiame in cui vennero caricati gli ebrei deportati, per 'provare le stesse sensazioni'. È un'idea assurda, senza senso, che fa dell'appropriazione del passato una vexata quaestio: anche perché ogni cittadino americano, eccezion fatta per i nativi, è comunque 'cittadino di qualcos'altro', e dunque si sente sempre il bisogno di trovare 'radici altre'. «Gli europei non sono da meno: c'è sempre qualcuno che rivendica radici padane», commenta sarcastico Lerner, facendo esplodere una risata fra il pubblico. Lerner conviene che la cultura aiuta a superare la rimozione della Storia e delle storie (ad esempio opere come "Le benevole" di Littell e "Middlesex" di Eugenides e, in tempi più lontani, "Vita e destino" di Vasilij Grossman), ma può desensibilizzare rispetto alle ingiustizie quotidiane che ci circondano. Mendelsohn ironizza spiegando che ha risolto questo problema «studiando la sofferenza nel suo primo libro, e infliggendola al lettore nel secondo». L'insegnamento dei classici è proprio questo: l'accettazione della sofferenza. Gli uomini contemporanei non sono più abituati a questo e, «se dovessero riscrivere l'Eneide al giorno d'oggi, cambierebbero il finale: Enea e Didone si sposerebbero». La partecipazione del pubblico è attenta, come testimoniano le domande finali: nasce quindi spontaneo un confronto fra l'attività di ricerca svolta da Mendelsohn e quella di padre Patrick Desbois, protagonista di un coinvolgente evento il giorno precedente al teatro Ariston. Lo scrittore americano spiega, per quanto l'interesse di entrambi sia nato dall'amore per il nonno, l'impegno del sacerdote sia più che altro una soddisfazione intellettuale, il ritrovamento di una tomba non può aiutare più di tanto nel ricomporre il passato dei nostri avi. Ad ogni modo, «a book is a better monument than a stone». E, in un ambiente come Festivaletteratura, non possiamo non dargli ragione. Thank you, Daniel.