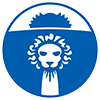08/09/2012
Raffaele La Capria con Silvio Perrella
2012_09_08_154
«Quanto alla biografia preferisco farla in negativo: non sono andato a cercare oro in Alaska e non ho percorso a piedi la Patagonia o l'Australia seguendo le vie dei canti (...). Nei miei libri qualche traccia della mia biografia c'è, perché dopotutto potrei dire come Montaigne che sono io stesso la materia dei miei libri». I libri di Raffaele La Capria si possono leggere come i successivi stadi di evoluzione di un'unica opera mai conclusa, su cui l'autore è continuamente ritornato correggendo e annotando. Passando dalla narrativa alla saggistica, da Ferito a morte a La mosca nella bottiglia, fino all'ultimo Esercizi superficiali, La Capria parla di sé parlando d'altro e parla d'altro parlando di sé, tenendo il mare e Napoli come punti di riferimento imprescindibili.
Lo incontra Silvio Perrella, curatore del volume delle Opere di La Capria.
Lo incontra Silvio Perrella, curatore del volume delle Opere di La Capria.
English version not available
Italiano
«Ho novant'anni, la fortuna di aver trascorso la giovinezza quando il mare era più trasparente, il cielo più intatto, la terra vergine ed incontaminata: allora il mare, il cielo, la terra erano quelli che erano sempre stati, quelli che avevano visto tutti gli uomini prima di me. Dopo il 1942, il mare, il cielo, la terra non sono più stati gli stessi. E mi accompagna una nostalgia profonda, una nostalgia che coltivo perché non voglio scompaia, perché voglio che combatta, perché rivoglio quel mare trasparente, quel cielo intatto, quella terra vergine». Si commuove, Raffaele La Capria, e ci commuove, ci fa rimpiangere quella meraviglia ormai inaccessibile, quel paradiso perduto, quella bellezza distrutta che è il mar Tirreno, che ha scoperto con una maschera subacquea improvvisata, ricavata intagliando un pezzo di legno di fico e applicandovi un paio di lenti. Si sente come il suo cuore tremi ancora ripensando a quella prima volta tra forme, colori e distanze che il tempo gli ha portato via, che l'uomo gli ha distrutto, rendendolo orfano del proprio posto al mondo. La Capria non lo dimenticherò mai, quell'universo d'acqua, quelle onde di gioia: sarà sempre al centro del suo cuore, dei suoi pensieri e dei suoi scritti. È il caso di "Posillipo '42", ambientato in una calda estate nel bel mezzo della guerra, un racconto sulla contrapposizione tra un giovane napoletano, immerso nelle acque antistanti il palazzo tufaceo di Sant'Anna, ed un aviatore americano che, dal proprio aereo, inizia a mitragliare quella distesa di calma e pace, quella tranquillità che non gli è permessa. Quel nuotatore mediterraneo è un La Capria ancora fanciullo, ancora in attesa della chiamata alle armi, un La Capria che cerca nel mondo marino una cattedrale del silenzio, in cui cessa il rumore della guerra e delle bombe e si entra, come scriveva Orwell, nel ventre della balena, dove l'unico modo per sopravvivere è rimanere umani. Nonostante i venti libri di cui è autore, La Capria rimane per antonomasia «lo scrittore di "Ferito a morte"», il romanzo che si apre con l'immagine di un ragazzo in dormiveglia, all'alba: un raggio di luce mediterranea entra prepotentemente dalle fessure delle persiane, un annuncio della bella giornata che inizia, una uguale alle altre, una qualsiasi, in cui non accade nulla di speciale. Eppure, l'idillio è attraversato da un'ombra: l'uccisione di una sogliola, la morte di un polpo, tutte metafore della felicità che non ci è mai destinata, che ci viene negata dagli dei e dalla loro Nemesi. Un'ombra che è storia di un uomo, di tutti gli uomini, di una città, Napoli, che ha perso la possibilità di diventare moderna, di riscattarsi, di emanciparsi, di alzare la testa e combattere il pregiudizio, l'ovvietà di una mentalità atavica. Silvio Perrella, ad accompagnarlo, ricorda la battaglia di La Capria per non essere definito «scrittore napoletano, perché quando pensi a Moravia, non dici scrittore romano, o a Pavese come scrittore torinese». Nell'antica Grecia, il saggio era l'uomo dell'armonia tra sé e gli altri, tra sé e la città, tra l'uomo e gli dei, tra l'uomo e la natura. Proprio per questo, La Capria non è scrittore napoletano, ma uomo greco, saggio greco, come Napoli, Nea Polis, è città greca, culla greca. La Capria è un saggio mediterraneo, ma non appartiene a nessuna città, soltanto al suo mare.