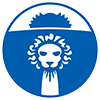09/09/2012
Pierluigi Cappello con Elia Malagò
2012_09_09_180
Pierluigi Cappello nel 2004 ha vinto il premio Montale Europa con Dittico e nel 2006, con Assetto di volo, raccoglie la produzione poetica in lingua e in friulano dal '94. È con Mandate a dire all'imperatore (2010) che, oltre a imporsi al Viareggio-Repàci, ottiene il consenso unanime di pubblico e critica. «In Cappello il luogo del poeta è zona viva tra un respiro e l'altro, qui e ora, lo spazio che si fa tempo, tempo e spazio che si fanno confine, orlo, soglia», annota Giovanni Tesio. E, a dire del poeta stesso, è il momento in cui «il silenzio si raddensa in gola davanti a qualcosa di inesprimibile; è l'ultima carta da giocare per conquistare alla parola qualche lembo ulteriore di realtà». Lo incontra Elia Malagò.
English version not available
Italiano
Quelli di poesia sono incontri in sordina, poco pubblicizzati, appoggiati di tanto in tanto nelle agende dei festival come perline d'argento che fanno da intermezzo ad altre pietre preziose più appariscenti. Ora, immaginatevi una stanza piena di persone - silenziose, in attesa - e due figure sedute, sullo sfondo - una piccolissima signora bianca e un uomo - che iniziano a parlare, a raccontare la loro storia: la storia di quel momento. L'uomo - il poeta - è Pierluigi Cappello e come scusandosi, si inserisce nella sua presentazione: le biografie che diffonde non sono mai attendibili, ma questa volta è stato scovato, smascherato, esposto. Lo dice sorridendo, ripensando a suoi vecchi titoli che forse ha riposto in un recondito scaffale della libreria - di quelli troppo in alto o troppo in basso - o in seconda fila, una volta averli liberati dal cassetto. La cosa che stupisce, di cui non ci si accorge subito, è che Cappello è disabile: ha perso l'uso delle gambe dopo uno sfortunato incidente in moto, lui giovane promessa dei cento metri, con il sogno dell'aviazione. Sabato sera, a Palazzo Te, Cappello ha fatto un intervento sulla follia ariostea e istantaneamente ci sembra di risentire "La follia" corelliana e di vedere l'estratto de "Le cose che parlano" (film di Tiziana Bosco), dove la musica non ha direzioni - come si chiamano in gergo - e ogni frase sembra sussistere su - e in - se stessa: come lo sguardo del personaggio in primo piano sullo schermo. La poesia di Cappello - come fa notare Elia Malagò, che lo introduce - è legata a doppio filo al cinema realista e questo sguardo guardato ci rimanda a quella scena di "Amarcord" dove i personaggi aspettano nella nebbia l'arrivo del "Transatlantico Rex". Vediamo i loro sguardi e l'epifania si compie, lo svelamento è in atto, ma non sul volto dei personaggi, bensì su quello del personaggio - che riprende, che guarda. Vedono passare l'angelo, ma non sanno che l'angelo sono loro stessi, con i loro sguardi. In "Mandate a dire all'Imperatore", le parole sono più urgenti della grammatica e l'esercito di personaggi che il libro ospita - con i loro oggetti, «ognuno con il suo tozzo di storia e il proprio nome» - si avvalgono di una parola aggiustata per l'occasione. Il poeta trae linfa vitale e affonda le sue radici pazienti, resistenti, ostinate - già scosse dal terremoto del '76, a causa del quale fu costretto a sfollare da Chiusaforte - nella sua terra: il Friuli. Terra di confine, dura e duttile allo stesso tempo, come le parole che usa, di cui anche le più aspre accolgono un mallo di dolcezza. Il confine è «una marca di fibra speciale, ferma e mobile contemporaneamente.» Cos'è dentro? Cos'è fuori? Insegna a guardare le cose con gli occhi di chi è guardato. «Vai dunque laggiù? Come sarai lontano. Lontano da dove?», scrive Saint-Exupéry. Il confine aiuta ad aprire gli orizzonti, ad ampliare il campo visivo, come in una prospettiva aerea. "Assetto di volo" - raccolta che per Cappello funge da fucina, laboratorio, apprendistato alla poesia e alla vita - sembra riferirsi proprio a questo. Vivere negli anni '70 a Chiusaforte era come vivere negli anni '50, dice il poeta, e vivere negli anni '50 significava vivere, crescere, formarsi e morire come nell'Ottocento. Il 1976 ha scaraventato il Friuli nella modernità e il trapasso alla consapevolezza dell'età moderna è stato violento e velocissimo, brutale. Le lezioni di italiano, a scuola, erano un isola sul mare mosso del friulano (lingua in cui il poeta tuttora pensa). Nei locali pubblici - nel municipio - si parlava in dialetto: la lingua del lavoro, del gioco, dell'amicizia, della prossimità alla natura. Un altro avvenimento storico che contribuì a scuotere il Friuli, anche se apparentemente lontano, fu il crollo del muro di Berlino: l'est premeva alle porte. Questa lingua risente semanticamente delle influenze slave e russe, di cui condivide la stessa sensibilità. Molte parole hanno una doppia valenza e accolgono una perfetta corrispondenza tra la natura e l'ideologia. "Salustri", ad esempio, designa lo squarcio di azzurro tra due rovesci, «come se il cielo trattenesse il respiro per incassare meglio la tempesta futura», ma anche l'ultimo lampo di lucidità che ha un agonizzante prima della morte (e il pensiero è a Tolstoj e a Ivan Il'ič). Le lingue sono luoghi e questo tipo di bilinguismo consente di avere una pronuncia di se stessi e degli altri più ampia; il friulano è la lingua del mondo interiore che si esprime, la lingua di quel "me donzel" pasoliniano, della teatralizzazione dell'io, l'italiano le va in soccorso dove non può arrivare. «Come i semi dei fiori importati, ho sognato di raggiungere i miei morti». In questi versi possiamo dire di ritrovare quella foscoliana «corrispondenza d'amorosi sensi» o il silenzio della sequenza finale di "Ladri di biciclette": la mano del bambino che entra in quella del padre senza doversi rivolgere altro sguardo, camminando con gli occhi fissi davanti a sé - verso lo spettatore - passando dalla vergogna alla mite certezza della propria dignità e insieme con loro è il mondo intero, che cammina nel giusto.