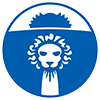06/09/2013
RITROVARSI TRA LE ROVINE
2013_09_06_109
C'è una geografia silenziosa, nascosta fra le pieghe del nostro territorio. è fatta di case golenali lasciate alla natura del fiume, paesi abbandonati dell'Appennino, capannoni industriali inutilizzati. Rovine senza dignità monumentale, che sembrano arrivare non si sa bene da dove. Sono i resti di un paese che non c'è più o di un futuro tradito, a cui occorre ridare voce perché ci raccontino che cosa eravamo, che cosa avremmo voluto essere. Due narratori - Michela Murgia e Giorgio Vasta - e una storica - Antonella Tarpino, autrice di "Spaesati" - provano a restituirci i mondi e le vite trattenute dalle rovine sparse per l'Italia. Perché «sta a noi», scrive Antonella Tarpino, «far sì che la rovina ci esenti non tanto dal senso della fine, ma dalla fine del senso di noi stessi».
English version not available
Italiano
Il confronto inatteso e coinvolgente tra due scrittori, Michela Murgia e Giorgio Vasta, e tra la storica Antonella Tarpino, autrice di "Spaesati", abbraccia contesti e situazioni diverse. Gli spunti sono molteplici. Gli spazi pieni e vuoti sono costruiti da poteri non democratici, demolire e ricostruire decreta la forza di chi governa. La democrazia ricompone il senso della temporaneità come pacifico valore.
C'è una bella differenza tra vecchio e antico, termini apparentemente simili che portano alla luce tutte le contraddizioni della nostra memoria breve. Il Novecento è un grande produttore di macerie che non hanno nulla da dire, come i volti industriali delle nostre periferie. Ma per Giorgio Vasta, la rovina è un qualcosa da aggiustare come un marchingegno. In una città come Palermo o come gran parte del Sud d'Italia, è la quotidianità; la riparazione è l'eccezione e lo stupore che ne deriva è lo 'spaesamento'. Questi sono i paradossi del presente.
"Spaesati" ci presenta una mappatura tutta italiana di paesi fantasma: sono circa 3000 secondo le stime FAI e Confcommercio. Un terzo del territorio in abbandono. Lontani dalle consuete rotte dei viaggiatori, ma mete di un turismo snob, spesso il ripopolamento non è la risposta migliore perché la ricostruzione accantona il confronto con la memoria storica.
Le rovine sono luoghi, pezzi straordinari e possono essere esperimenti di futuro, raccontano qualcosa e ti fanno pensare. «Ho imparato che i vuoti e i pieni delle rovine hanno un linguaggio proprio. Mi hanno insegnato che oltre la storia corta c'è una storia lunga». Questo linguaggio ci indica, innanzitutto, un limite che è fragilità dovuta alle catastrofi ambientali e umane.
Il ritorno a quei mondi è anche un aprirsi al nuovo, al mondo globale per incanalare energia nuova. Il prendersi cura di ciò che è andato perduto non ha nulla a che vedere con la nostalgia o l'anacronismo, ma significa preparare il terreno per un futuro prossimo. Riace, in Calabria, è un esempio folgorante di rinnovamento: il piccolo paese, prima abbandonato, ospita i profughi di un Mediterraneo in fiamme.
È un terremoto che salva lo spirito e le macerie.
C'è una bella differenza tra vecchio e antico, termini apparentemente simili che portano alla luce tutte le contraddizioni della nostra memoria breve. Il Novecento è un grande produttore di macerie che non hanno nulla da dire, come i volti industriali delle nostre periferie. Ma per Giorgio Vasta, la rovina è un qualcosa da aggiustare come un marchingegno. In una città come Palermo o come gran parte del Sud d'Italia, è la quotidianità; la riparazione è l'eccezione e lo stupore che ne deriva è lo 'spaesamento'. Questi sono i paradossi del presente.
"Spaesati" ci presenta una mappatura tutta italiana di paesi fantasma: sono circa 3000 secondo le stime FAI e Confcommercio. Un terzo del territorio in abbandono. Lontani dalle consuete rotte dei viaggiatori, ma mete di un turismo snob, spesso il ripopolamento non è la risposta migliore perché la ricostruzione accantona il confronto con la memoria storica.
Le rovine sono luoghi, pezzi straordinari e possono essere esperimenti di futuro, raccontano qualcosa e ti fanno pensare. «Ho imparato che i vuoti e i pieni delle rovine hanno un linguaggio proprio. Mi hanno insegnato che oltre la storia corta c'è una storia lunga». Questo linguaggio ci indica, innanzitutto, un limite che è fragilità dovuta alle catastrofi ambientali e umane.
Il ritorno a quei mondi è anche un aprirsi al nuovo, al mondo globale per incanalare energia nuova. Il prendersi cura di ciò che è andato perduto non ha nulla a che vedere con la nostalgia o l'anacronismo, ma significa preparare il terreno per un futuro prossimo. Riace, in Calabria, è un esempio folgorante di rinnovamento: il piccolo paese, prima abbandonato, ospita i profughi di un Mediterraneo in fiamme.
È un terremoto che salva lo spirito e le macerie.