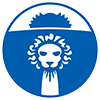06/09/2013 - Il paese più straniero
LA VOCE DI VIRGILIO
2013_09_06_112
«Se si torna così di frequente a reinterpretare e a riscrivere Virgilio, è proprio perché ogni generazione ha i suoi nuovi e peculiari interrogativi da porgli». Alessandro Fo si è recentemente cimentato nell'impresa di riproporre la voce di Virgilio, una voce - come scriveva Carlo Emilio Gadda - che sembra insorgere «da un profondo sacerdozio della tenebra» e il cui sentimento scaturisce da una fonte che «è insieme lo sgomento e la panica delizia del vivere, del conoscere». Insieme al giornalista Roberto Andreotti, Fo ripercorre il lungo lavoro in dialogo con Virgilio sull'"Eneide", nel tentativo di restituire attraverso una traduzione metrica, una lingua apparentemente vicina al parlato, in realtà costantemente orientata verso il sublime.
English version not available
Italiano
«Ogni generazione deve avere il suo Virgilio», con queste parole Roberto Andreotti ci introduce alla nuova traduzione dell'"Eneide" portata a termine da Alessandro Fo per Einaudi. L'accento è sulla capacità di rigenerazione della voce virgiliana, che ha attraversato i secoli grazie alla staffetta dei traduttori che si sono passati il testimone. A questa 'catena umana' (Andreotti parafrasa qui il titolo di una raccolta di liriche di Seamus Heaney, altro grande studioso di Virgilio), che comprende anche nomi illustri come Leopardi e Carducci, Alessandro Fo aggiunge il suo anello e stasera ci spiega come ha operato per ottenere questo risultato, una traduzione che la quarta di copertina definisce «particolarmente tecnica e intimamente poetica».
Fo e Andreotti, dotti studiosi, insistono molto sugli aspetti tecnici della resa del testo: la scelta dei versi al posto della prosa, preferita dai traduttori contemporanei, l'opzione di un esametro barbaro, che cerca di riprodurre l'originale latino nonostante la nostra lingua abbia perso il senso della quantità delle sillabe, la decisione di conservare la ripetitività dei versi formulari, la riproduzione degli arcaismi, i problemi posti dalle enallagi e dallo stilema virgiliano del tema-variazione, definito così da James Henry.
Ma, aspetti tecnici a parte, il pubblico si appassiona soprattutto alla dimensione poetica di un'opera scaturita dal dialogo profondo tra due poeti (Fo è autore di numerose raccolte liriche), seppur vissuti a distanza di millenni. Un dialogo affettuoso, ma anche problematico, perché la voce del poeta latino è enigmatica e sfuggente, anche per chi ha trascorso quasi quattro anni a volgerli in italiano quei versi conservano sempre un quid inespresso, restano 'fasciati di mistero'. Del resto, ci viene spontaneo ricordare, non deve essere un caso se in epoca medievale Virgilio veniva visto come un profeta che nella quarta egloga aveva vaticinato l'avvento di Cristo, o addirittura come un mago o uno sciamano, intorno al quale circolarono a lungo leggende e superstizioni. Il rapporto con il poeta latino si è fatto talmente intimo che, parlando del suo lavoro di traduzione, delle difficoltà incontrate, Alessandro Fo non può fare a meno di accennare, con molta eleganza, anche ai problemi personali che lo hanno afflitto nei quattro anni in cui si è dedicato all'"Eneide": «anche io ho sepolto il mio Anchise», e, pensiamo noi, senza poter avere la fortuna di Enea, che viaggiando da vivo nell'Ade, reincontra il padre un'ultima volta. Chissà quanta profonda malinconia dovendo tradurre quello struggente «ter frustra comprensa manus effugit imago», con cui l'eroe troiano tenta invano di abbracciare l'ombra di Anchise, che gli sfugge tra le mani. Nonostante le avversità, comunque, Fo ha portato a termine i dodici libri del poema, e ora come il naufrago dantesco «si volge all'acqua perigliosa e guata», esclamando umilmente «io speriamo che me la sono cavata».
Fo e Andreotti, dotti studiosi, insistono molto sugli aspetti tecnici della resa del testo: la scelta dei versi al posto della prosa, preferita dai traduttori contemporanei, l'opzione di un esametro barbaro, che cerca di riprodurre l'originale latino nonostante la nostra lingua abbia perso il senso della quantità delle sillabe, la decisione di conservare la ripetitività dei versi formulari, la riproduzione degli arcaismi, i problemi posti dalle enallagi e dallo stilema virgiliano del tema-variazione, definito così da James Henry.
Ma, aspetti tecnici a parte, il pubblico si appassiona soprattutto alla dimensione poetica di un'opera scaturita dal dialogo profondo tra due poeti (Fo è autore di numerose raccolte liriche), seppur vissuti a distanza di millenni. Un dialogo affettuoso, ma anche problematico, perché la voce del poeta latino è enigmatica e sfuggente, anche per chi ha trascorso quasi quattro anni a volgerli in italiano quei versi conservano sempre un quid inespresso, restano 'fasciati di mistero'. Del resto, ci viene spontaneo ricordare, non deve essere un caso se in epoca medievale Virgilio veniva visto come un profeta che nella quarta egloga aveva vaticinato l'avvento di Cristo, o addirittura come un mago o uno sciamano, intorno al quale circolarono a lungo leggende e superstizioni. Il rapporto con il poeta latino si è fatto talmente intimo che, parlando del suo lavoro di traduzione, delle difficoltà incontrate, Alessandro Fo non può fare a meno di accennare, con molta eleganza, anche ai problemi personali che lo hanno afflitto nei quattro anni in cui si è dedicato all'"Eneide": «anche io ho sepolto il mio Anchise», e, pensiamo noi, senza poter avere la fortuna di Enea, che viaggiando da vivo nell'Ade, reincontra il padre un'ultima volta. Chissà quanta profonda malinconia dovendo tradurre quello struggente «ter frustra comprensa manus effugit imago», con cui l'eroe troiano tenta invano di abbracciare l'ombra di Anchise, che gli sfugge tra le mani. Nonostante le avversità, comunque, Fo ha portato a termine i dodici libri del poema, e ora come il naufrago dantesco «si volge all'acqua perigliosa e guata», esclamando umilmente «io speriamo che me la sono cavata».