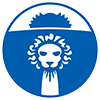09/09/2009
AFRICA AD ALTA VOCE
2009_09_09_004
Dove sta andando la letteratura africana del nuovo millennio? Ne discutono un premio Nobel, poeti, performer e narratori migranti. Conduce Peter Florence, organizzatore di Hay Festival Storymoja, Nairobi.
English version not available
Italiano
Inglese
Inglese
Nel cortile della Cavallerizza del Palazzo Ducale, Peter Florence introduce quattro voci del continente africano, quattro voci inascoltate che si esprimono contro le oppressioni dei popoli africani, alle quali chiede fino a che punto gli autori si sentano voci della propria comunità e quanto si sentano responsabili per ciò che scrivono. Per lo scrittore ugandese Timothy Wangusa ognuno scrive a seconda della propria ispirazione, ma allo stesso tempo è membro della propria comunità e ne è dunque responsabile. Il Premio Nobel per la letteratura Nadine Gordimer cita Milan Kundera «Quando uno scrittore cessa di essere qualcosa in più di uno scrittore, allora cessa di essere uno scrittore». Per Gordimer scrivere non è dare risposte, ma porre domande. Secondo la scrittrice nigeriana Chika Unigwe, autrice di "Nigeriane", le storie che raccontano di donne africane portate in Europa per la prostituzione sono storie moderne e devono, quindi, essere raccontate. L'autrice sudafricana Natalia Molebatsi sostiene che scrivere significa coinvolgere il pubblico e, come Gordimer, porre domande; anche se l'intento non è politico, le implicazioni politiche sono interconnesse, che lo si voglia o no. Di fronte al pubblico che riempie la tensostruttura e si siede sull'erba attorno al palco, il moderatore Florence affronta il problema della scrittura in una lingua non nativa, come è il caso del fiammingo per Chika Unigwe e dell'Inglese per altri, lingua che, pur essendo quella corrente non è la nativa dei popoli africani. Le opinioni a riguardo sono differenti: per Chika è un dato di fatto, la colonizzazione ha lasciato la lingua del colonizzatore e ora viene usata nella scrittura; molti scrittori africani la considerano un'imposizione, altri, invece, una scelta, e altri ancora un'opportunità di utilizzare una lingua di ampia diffusione. Nadine Gordimer ricorda, poi, come alcuni autori africani arricchiscano l'inglese con espressioni locali, africane. Alcuni movimenti locali volti ad incitare la scrittura nella lingua nativa stanno avendo successo nel teatro, dove le incomprensioni della lingua parlata vengono superate con il linguaggio del corpo. Il Cortile della Cavallerizza è gremito, sono ben poche le sedie vuote e solo fino a pochi minuti prima dell'inizio del dibattito, perché, quando Peter Florence, il moderatore, inizia a presentare gli autori sul palco, il colore multiforme della folla ha già completamente oscurato l'azzurro delle ultime sedie vuote. Sul palco, stretti dietro un tavolo che a stento contiene le loro sagome, ci sono alcuni degli esponenti di una letteratura, quella africana, che difficilmente si lascia inquadrare. Le domande di Florence danno ritmo al dibattito, il cui incalzare è spezzato solamente dalle necessarie pause per la traduzione: «Qual è il ruolo di uno scrittore? E in particolare, qual è il ruolo di uno scrittore africano? Che rapporto avete con la lingua, quella dei bianchi colonizzatori, che vi trovate a dover utilizzare?». Nadine Gordimer, la scrittrice sudafricana premio Nobel nel 1991, è la stella della serata, gli occhi del pubblico sono solo per lei. Inizia citando Milan Kundera: «quando non sarò altro che uno scrittore credo che smetterò di scrivere» diceva il ceco. E la Gordimer è della stessa opinione: «quando scrivo non smetto mai di essere un essere umano. Il mio ruolo, in quanto scrittrice è porre delle domande, rendere la complessità del mondo in cui vivo, non semplificarlo». Il microfono gira, le domande incalzano anche gli altri invitati al dibattito (la sudafricana Natalia Molebatsi, la nigeriana Chika Unigwe e l'ugandese Timothy Wangusa) e le loro risposte, come tasselli di un puzzle, si incastrano e completano quelle della Gordimer componendo un'immagine compatta, di una letteratura tutt'altro che costretta nei confini della lingua dei colonizzatori, ma libera di ricreare, arricchire e ampliare quella stessa lingua, l'inglese, e farla diventare il suono dei senza voce. Frederic Mistral, in altri tempi e altri luoghi, diceva che quando un popolo cade in schiavitù, se conserva la propria lingua, ha nelle mani le chiavi che lo libereranno dalle catene. Questa sera, nel cortile della cavallerizza, alcuni uomini e donne che quella schiavitù l'hanno vissuta, hanno dimostrato che, anche usando la lingua degli oppressori, quelle catene possono spezzarsi.